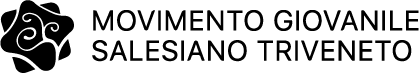News 5
Il mio eroe e il dolore
Qualche volta ho provato a chiedermi cosa ha imparato il mio eroe giovanile frequentando il baratro dei suoi poveri. Se io avessi già trovato la risposta, forse sarei pronto per la vita eterna, ma è evidente che mi resta ancora molto da scoprire. L'universo segreto delle risposte che lui ha già avuto in Paradiso e io no.
Il mio eroe e il dolore
Il tremore del Ragioniere fa cigolare la vecchia sedia a rotelle. Ha un cerotto sulla tempia perché si è grattato tutta notte, fino a scavarsi. Lo stimolo del prurito, nel suo cervello in cortocircuito, vince su quello del dolore. E a volte si riduce così. E’ stato pure sui giornali quando fratel Ettore lo ha catturato. Era detto “il cavernicolo della Centrale” perché si aggirava tra le sale d’attesa con i piedi scalzi (e neri), gli abiti a brandelli e i capelli lunghi fino a terra. La gente aveva paura, e lui di più. Il nuovo battesimo lo aveva ricevuto una volta ripulito e messo a letto. Visti i calcoli che continuava a ripetere, probabilmente era stato un contabile. Anche se non lo era stato, da quel momento e per sempre si chiamava “il Ragioniere”. Un bel salto di qualità: da uomo preistorico a diplomato.
Il Ragioniere è uno dei sessanta poveri con cui trascorro parte del mio tempo. E’ la famiglia messa insieme da fratel Ettore Boschini, il camilliano folle e profetico che nell’ultimo trentennio del ‘900 ha fatto scuola di carità a Milano. Io sto con loro col compito di mettere in piedi degli spettacoli teatrali. Ma la mia è un’altra (bellissima) storia.
La storia del Ragioniere assomiglia a quella dei suoi vicini di posto. In questo periodo tutti e sessanta stanno stipati nella “cappellina invernale”, che si differenzia dalla “chiesa estiva” non per il maggiore riscaldamento, ma per la minore superficie da rendere temperata con gli aliti. Con accenti sconosciuti, biascicamenti, rutti, ognuno dice il rosario a suo modo, ottenendo però un salmodiare compatto, che è prerogativa delle vere comunità. I sessanta ex barboni in pensione fanno concorrenza al Crocifisso che li scruta. Ognuno esibisce gemendo la sua patente di inchiodato. Un composito corpo agonizzante che prega, che respira (non si sa ancora per quanto), che si assopisce. Gambe mozzate, nervi a pezzi, postumi della poliomelite o dell’alcool. Il visitatore in cerca di uno spunto per meditare sui Misteri del dolore, qui non ha che l’imbarazzo della scelta.
Concentrare in pochi metri quadri una tale mole di sventure non sembra una operazione dettata dal buon senso. A molti parrebbe più logico spalmare le sofferenze di pochi sul resto dell’umanità più fortunata, in modo che ogni, diciamo, cinque panche di gente sana e benestante, ci sia una sedia a rotelle da accudire. Purtroppo il mondo non gira secondo le nostre giuste intenzioni, e i disperati stanno ai margini, non chiedono aiuto e, pure se glielo offri, fanno di tutto per non farsi salvare. Per occuparsi di loro è necessario uscire dagli schemi e, possibilmente, anche di casa. Per occuparsi di loro bisogna essere sordi agli insulti, insensibili al vomito sui sedili della propria auto, in grado di dormire vicino a uno sconosciuto che molto probabilmente cercherà di soffocarti nel sonno. Un tale coraggio io l’ho conosciuto solo in fratel Ettore, ed è per questo che per quanto mi riguarda spetta a lui, e non ai “molti”, il diritto di decidere le regole di convivenza di centinaia di esseri umani in dismissione.
La differenza tra fratel Ettore e noi gente comune non sta tanto nella commozione davanti alle ingiustizie, che tocca tutti i cuori. La differenza sta nel livello di urgenza del sovrannaturale da cui si è posseduti. Solo in cerca di un Principio Eterno si scende nelle cantine abbandonate della Stazione Centrale, sotto la minaccia delle siringhe infette dei tossici, tra le urla delle prostitute appena stuprate e derubate, scoprendo piaghe abitate dagli insetti. Questo non si fa perché si ha buoncuore, si fa se si è tenuti sulle spine dalla santa inquietudine che può muovere o a Dio, o alla propria rovina.
Fratel Ettore non era un filantropo. Certo, non poteva vedere la gente lasciata a marcire sul marciapiede, ma c’è forse qualcuno che ama un tale spettacolo? La virtù eroica di Fratel Ettore stava nella sua vera professione: indagatore del dolore. E’ una cosa ben diversa. Ecco perché rapiva i poveri. Per allestire i suoi centri di osservazione.
Fratel Ettore nel dolore ci viveva, ci sguazzava. Dolore non solo intorno, pure dentro. Nuovo di zecca o retaggio del passato. Un tumore mal superato, la colonna vertebrale compromessa dai lavori in campagna troppo presto, i denti rotti dalle botte dei suoi “amici”. In più l’assenza di cura, la mancanza di riposo, il cibo cattivo e trangugiato in piedi. Una povertà intransigente, che non sembra nemmeno sorellastra di quella beata delle leggende postume sui santi. Freddo provato sulla pelle, quello vero, che fa screpolare. E mancanza di crema idratante, di guanti senza buchi, di suole. Proprio in questo rapporto (dolore-povertà) c’è una prima chiave che apre il talento numero uno del soffrire: il dolore è privazione, obbliga pure i più cocciuti all’abbandono.
La mia modesta anima di adolescente rimase folgorata da una frase di Fratel Ettore a prima vista proprio banale: “Se io non credessi che c’è Gesù nei poveri, uscirei fuori subito, e andrei a prendermi un gelato”. Io lo vedo ancora quel gelato, pietrificato in potenza, quella delicata allusione a una soddisfazione infantile, che per me è stata un’esplosione. Mi ha detto meglio di una omelia la fatica concreta di chi rinuncia senza sosta per servire. Sembra scontato, sembra un dovere, lui è santo e noi no. Invece, con quella affermazione, facevo la conoscenza di un inedito Ettore senza il “fratel”, affaticato e umanissimo nemico di minuscole gioie fuorvianti.
Fratel Ettore rimestava i catini di pianto per vederci chiaro sotto, tolta la patina nera e densa. Aveva ricevuto in dono un indizio-chiave che ogni uomo educato nella fede possiede: “Scava nel fango, vale la pena”. Con fiducia, eseguiva. Più disperati si caricava sulle spalle, più sprofondava e si illuminava.
Qualche volta ho provato a chiedermi cosa ha imparato il mio eroe giovanile frequentando il baratro dei suoi poveri. Se io avessi già trovato la risposta, forse sarei pronto per la vita eterna, ma è evidente che mi resta ancora molto da scoprire. Posso solo balbettare qualche intuizione, per lo più negativa: fratel Ettore non ha imparato dai suoi poveri un metodo stoico per affrontare il dolore, perché quasi tutti sono ignoranti e lo vivono malissimo, con imprecazioni e lamentele; non ha imparato dai suoi poveri come scamparle, le sofferenze, dato che loro, per primi, hanno sperimentato mille maniere di rovinarsi salute e anima. Di certo ha osservato molti casi in cui l’asfissia di una tragedia personale ha dato ossigeno a chi si avvicinava con compassione. Non è un effetto positivo sul derelitto, ma può indicare un secondo talento che agisce, diciamo, per riflesso: il pianto feconda.
C’è poi la parte più eccitante, perché ancora incartata: l’universo segreto delle risposte che lui ha già avuto in Paradiso e io no. Tipo: a che giova il buco sulla tempia del Ragioniere? Chi glielo spiega che può essere uno strumento di redenzione se non capisce nemmeno come si chiama? Vaglielo a dire che il suo corpo sfasciato non è inutile, ma serve all’accumulo di punti-paradiso dei bravi volontari che gli allacciano il maglione.
Con tutte queste cose la mia interiorità preferisce per ora non avere troppo a che fare. Mi accontento di fidarmi, di leggere gli indizi che mi dicono che poi sarà così facile capire. O non servirà nemmeno, capire.
Un indizio l’ho avuto proprio da fratel Ettore, per bocca di un amico, pochi giorni fa. Mi ha raccontato commuovendosi che quando è andato a trovarlo poco prima che morisse, da dietro al vetro, dal citofono, ha gracchiato: “Mi sembra di vedere un angolo di Paradiso in terra”. Era esausto, pallidissimo, gonfio per il cortisone.
La cosa eccezionale, che fa davvero tremare i polsi, è l’improvvisa sparizione della catasta di copri derelitti dalle spalle del frate nel momento in cui lui, il buon samaritano in persona, si è trovato di fronte al suo stesso, personalissimo, dolore.
Per un eloquente contrasto, gli ultimi mesi di fratel Ettore sono trascorsi nella quiete inoperosa di una clinica milanese, in mezzo al candore accecante di lenzuola ben pulite, di garze sterili, di capelli soffici lavati con affetto dalle infermiere. Fratel Ettore, al colmo della sua avventura terrena, è stato privato della sua collezione di esempi vivi di disperazione. E’ stato trasferito in ambiente sterile, addirittura sottovetro, senza germi. Come a dire: fin’ora hai studiato; adesso non sbirci i testi, e dai l’esame.
E chi se lo immagina “il gigante della carità” senza il gusto di salvare una vita, di farsi picchiare, di tirare i rosari ai lavavetri, di guidare tutta notte, di cucinare il minestrone, di schizzarsi di calce, di contrarre la scabbia, di prendere fuoco per errore, di inginocchiarsi in autostrada, di regalare le sue scarpe quando nevica? Condannato alla pulizia, al silenzio, all’immobilità. E, come se non bastasse, proprio nell’istante fondamentale.
La caposala ricorda ancora con quale impeto, i primi tempi, chiedeva il telefono, con quale zelo domandava ancora un giorno, ancora un’ora, per poter finire di riparare un tetto, per poter ricordare quella cosa importantissima a quel caro collaboratore, per potersi dare ancora un po’ in pasto.
Ma era il momento della quieta obbligatoria. All’inizio gli ha fatto impressione. Poi ha capito perché proprio lì, proprio ai saluti. E allora che bello, finalmente, nessuno che ti tira la veste, che ti suona il campanello, che ti intervista in piazza Duomo. Avere il solo dovere di soffrire tu in persona, e meditare. E risoffrire. E sulla nuova sofferenza, un’altra volta, meditare.
Così è tornato a galla il primo impulso di quella esaltante, interminabile, logorante caccia al dolore: acciuffare una risposta che passa dagli altri, ma che serve alla propria anima, bene privato e personale. Sono fiero di svelarvi come fratel Ettore, sulla soglia della vita, ha avuto finalmente il coraggio di usare qualcosa per sé. E non ha più sentito male.
Emanuele Fant
Versione app: 3.13.5.6 (1e5e7c1)